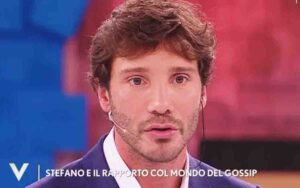C’è ancora chi giura che l’orizzonte sia una riga perfetta e che la Terra sia piatta. Non è solo un capriccio del web: è un mix di sfiducia, bisogno di appartenenza e una potente promessa implicita — “io vedo ciò che gli altri non vedono”. L’idea circola a ondate da oltre un secolo (dalle società “zetetiche” ottocentesche ai forum), ma i social le hanno dato amplificazione e comunità: video brevi che vanno virali, prove “casalinghe”, slogan semplici da ricordare. Ma perché funzionano? E qual è la verità?
Terra piatta: da dove nasce davvero l’idea
La leva principale è la percezione: “se non vedo la curvatura, allora non c’è”. Peccato che la Terra sia enorme: su distanze quotidiane la curvatura è minima e i nostri sensi non sono strumenti di precisione. Qui entrano in gioco i bias: la conferma (cerco solo contenuti che mi danno ragione), il Dunning–Kruger (sottovaluto la complessità), la preferenza per spiegazioni semplici a problemi complicati.
Cosa risponde la scienza, senza deridere? Che esistono misure ripetibili e molto concrete. Le navi che “spariscono” dalla chiglia in su seguono la curvatura. Le stelle visibili cambiano attraversando i paralleli. I fusi orari esistono proprio perché il pianeta è sferico e ruota. Con due bastoni, Eratostene nel III secolo a.C. calcolò la circonferenza della Terra misurando l’ombra del Sole in due città distanti. Oggi lo rifanno scuole e cittadini: funziona ancora. E poi ci sono i satelliti, i voli che “tagliano” gli oceani secondo rotte che hanno senso solo su un globo, le immagini da orbita bassa. Non servono formule esoteriche: serve metodo — misuro, confronto, replico.
Perché allora il mito resiste? Perché risponde a un’esigenza emotiva: dà un’identità, fa sentire speciali e autonomi dai “potenti”. Smontarlo non significa sbeffeggiare: significa proporre esperimenti semplici, raccontare come lavorano gli scienziati e perché cambiano idea quando i dati lo chiedono. La curiosità è un ottimo antidoto: toglie fascino al complotto e restituisce meraviglia al mondo.